DONNE E DESIGN
- romeo giammarini
- 19 feb 2024
- Tempo di lettura: 4 min
In un mio scritto di qualche settimana fa mi rallegravo della nuova considerazione che da qualche tempo viene riconosciuta alle donne designer che svolgono il loro lavoro a fianco di conclamati maestri del cosiddetto “movimento moderno”. L’occasione era data dalla mostra sulle mogli dell’architetto finlandese Alvar Aalto in corso al MAXXI di Roma, queste donne mi hanno fatto pensare ad altre importanti artiste finora considerate solo delle mere collaboratrici relegate in ruoli minori; da qualche tempo questa attenzione alla componente femminile non è solo mia, qualcosa sta cambiando, e non solo a Sanremo.
Di recente sono stato a Barcellona, e, ogni volta che ci torno, do un’occhiata al padiglione tedesco realizzato per L’Esposizione Universale del 1929, ricostruito nel 1986 alle pendici del Montjuïc. Questa volta sul pieghevole che illustra l’opera trovo una gradita sorpresa: “Mies van der Rohe e Lilly Reich ricevettero l’incarico della direzione artistica di tutta la sezione tedesca, la più estesa di tutta l’Esposizione”. Per tutto il testo dell’opuscolo sono sempre citati insieme, e vengono descritti come talenti complementari che diedero vita a una “estrecha e fructifera” collaborazione professionale dalla metà degli anni Venti fino al 1938, anno in cui Mies emigra, da solo, negli Stati Uniti.
Conoscevo il lavoro di Reich soprattutto per l’opera svolta nella Bauhaus (haus, in tedesco significa casa e, come in italiano, è femminile), dove entra, già matura e affermata professionalmente, come docente del laboratorio di tessitura e di quello di architettura degli interni, ma per la prima volta la trovo citata non come la compagna di Mies, ma come “coprogettista” alla pari del maestro di Aquisgrana.
La collaborazione dei due artisti ci ha lasciato alcune delle più significative opere di architettura e di design del XX secolo e alle idee di Lilly Reich si deve sicuramente la concezione spaziale fluida del Padiglione tedesco, filosofia che Mies porterà con se negli Stati Uniti. Ma ormai è a lei che viene attribuita la “maternità” dell’opera di design fino ad allora attribuita al solo Mies, le sedute in tubolare di acciaio a sbalzo del 1927, la poltrona e il pouf Barcelona pensati per i reali spagnoli in visita al Padiglione, gli interni della villa Tugendhat del 1930, uno dei capisaldi dell’architettura razionalista, con la poltroncina Brno pensata per quell’edificio.
Ormai è sempre più sviluppata, soprattutto all’estero, l’attenzione per il ruolo delle donne in architettura e nel design, in questo, come in altri campi, la Catalogna dimostra di essere avanti: si è appena chiusa al Museo del Design -il Disseny Hub di Barcelona, diretto da Pilar Vélez- una interessante mostra dal titolo “Som aquì, les dones en el disseny, 1900-avui”, che accende una luce sui notevoli contributi femminili alla storia del design da parte di artiste che fino ad ora hanno avuto scarso riconoscimento nei manuali di storia cercando di annullare quella sorta di “invisibilità femminile” con una nuova lettura più equa e inclusiva.
la mostra si basa su una proposta del Vitra Design Museum di Weil am Rhein (Germania) a cui il Disseny Hub di Barcelona ha affiancato una sua particolare ricerca sul lavoro delle donne spagnole, in realtà per la maggior parte catalane; la Spagna è un paese che per buona parte del XX secolo ha vissuto separato dalla modernità a causa di due diverse dittature, inframmezzate da una sanguinosa guerra civile, l’effetto di questa condizione è stato anche quello di reprimere il ruolo delle donne nella società. Alla fine del franchismo, nel 1975, la riacquistata libertà ha portato dagli anni Ottanta ad una esplosione di creatività anticonformista, paragonabile alla nostra degli anni Cinquanta; nella sezione catalana della mostra, intitolata “Cose di donne, cose da tutto il mondo, 1990-oggi”, ci sono oggetti contemporanei immaginati da giovani artiste, oggetti legati strettamente al mondo femminile, spesso in modo provocatorio, dimenticando quel pudore repressivo che ha accompagnato gli argomenti legati all’intimità femminile, o oggetti legati all’accudimento o alla terapia di malattie tipicamente femminili finora poco considerate, oggetti come un tampone mestruale a forma di dito o fasce porta bebè terapeutiche per bimbi prematuri o reggiseni decorati per donne mastectomizzate.
A questa impostazione della mostra del DHub fa eco il volume di Annabelle Hirsch Una storia delle donne in 100 oggetti; il libro, edito nel 2022 per Kein&Aber e edito in Italia nel 2023 da Corbaccio, è la risposta femminile alla Storia del mondo in 100 oggetti, raccolti dal direttore del British Museum Neil MacGregor tra quelli della collezione del suo museo, quella raccolta descriveva una storia dell’umanità declinata essenzialmente al maschile, il volume di Hirsch, invece, mette in risalto il contributo all’evoluzione dell’umanità da parte della “seconda metà” (de Beauvoir).
Gli oggetti legati alla storia delle donne sono, almeno fino ad una certa epoca, indissolubilmente legati al corpo e all’intimo, ai bisogni primitivi e di sopravvivenza, alle artes minores; è significativo che il primo “oggetto”, il più antico, non è un manufatto ma il risultato di una attitudine nuova, è un osso femorale guarito da una frattura: 30.000 anni fa in un essere umano si sviluppa l’attitudine alla protezione e all’accudimento di un suo simile ferito, questa scoperta apre prospettive nuove all’interpretazione del ruolo delle donne all’evoluzione umana, non più la “metà debole” (secondo Paolo di Tarso) e che, in quanto tale, andrebbe protetta, ma attiva al pari dei maschi e in grado di proteggere quelli che del suo gruppo erano deboli: gli infermi e i cuccioli, parte forte quindi, come afferma Franco Cardini ribaltando la vulgata comune, suggerendo che il serpente della tentazione biblica va da Eva perché sa che, se riuscirà a convincere lei, elemento preminente della coppia, avrebbe avuto tutti e due alla sua mercè.







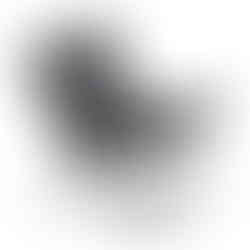





Comments